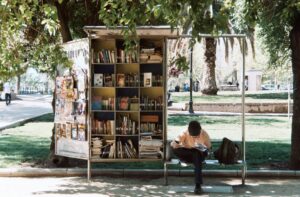Emergenza abitativa: in Italia la rendita immobiliare vale più del lavoro
In Italia la casa è spesso vista soprattutto come un investimento o un bene di mercato, più che come un diritto fondamentale. Sarah Gainsforth, in “L’Italia senza casa”, analizza come negli ultimi trent’anni questa prospettiva abbia cambiato il ruolo della casa e portato a una crescente emergenza abitativa.
Tempo di lettura: 5 minuti

di Valentina Ciannamea
Giornalista esperta di mondi digitali con un background da sociologa

In Italia parlare di casa significa quasi sempre parlare di investimento, di valore immobiliare, di mercato. Raramente si parla di diritto all’abitare. Questo slittamento non è casuale: dietro c’è un modello economico e politico che negli ultimi trent’anni ha progressivamente trasformato la casa da bene d’uso a leva finanziaria. Sarah Gainsforth, giornalista e autrice di L’Italia senza casa. Politiche abitative per non morire di rendita (Laterza, 2025), ricostruisce la genealogia di questa trasformazione e spiega perché oggi ci troviamo davanti a una nuova emergenza abitativa.
«La mia vita in affitto è diventata ricerca»
«Vengo da una famiglia straniera che ha sempre vissuto in affitto, io stessa a Roma ho sempre fatto fatica a trovare casa», racconta Gainsforth. «Per questo mi occupo di abitare da prospettive diverse: biografiche, giornalistiche, accademiche. Con “L’Italia senza casa” ho voluto mettere insieme i tasselli di una storia lunga, per capire come si sia arrivati a un modello in cui la rendita immobiliare ha sostituito il lavoro».
Il libro ricostruisce il percorso dalle politiche pubbliche degli anni Sessanta e Settanta – che avevano favorito l’emersione del ceto medio – al loro smantellamento dagli anni Novanta in poi. «Il ceto medio è una storia domestica», spiega Gainsforth, «perché è nato e si è consolidato grazie a politiche sulla casa e sul lavoro. Quando queste politiche sono venute meno, anche il ceto medio ha iniziato a sgretolarsi».
La casa come rendita, non come diritto
Oggi, come spiega Gainsforth citando l’Economist, siamo nell’epoca dell’“ereditocrazia”: conta di più ciò che ereditiamo che ciò che guadagniamo. «Negli anni Ottanta, una lavoratrice come un’infermiera poteva pagare mutuo o affitto con un quinto del salario. Oggi è impossibile. Chi non ha una casa di famiglia alle spalle è escluso».
Il nodo sta nella trasformazione della casa da bene d’uso a bene d’investimento: «Dagli anni Novanta in poi il mercato immobiliare ha assunto un ruolo centrale. E non è vero che non ci sono politiche: ci sono, ma vanno in direzione opposta al diritto all’abitare. Favoriscono la finanziarizzazione e la rendita».
Milano come modello (distorto)
Uno degli esempi più evidenti è Milano, dove il comune ha stanziato 210 mila euro per aiutare i giovani lavoratori a pagare l’affitto come bonus under 35. «Ogni crisi economica in Italia si affronta con misure edilizie: dal bonus 110 ai grandi progetti di rigenerazione urbana. Ma queste operazioni rispondono più agli interessi immobiliari che ai bisogni della città», osserva Gainsforth. «Il risultato è un meccanismo vecchio decenni: estrarre ricchezza dal suolo. Oggi avviene con studentati privati, centri direzionali, quartieri di lusso. E intanto chi lavora a Milano non può permettersi di viverci».
Oltre i bonus, servono politiche strutturali
«Misure come il bonus affitti per under 35 non bastano», sottolinea Gainsforth. «Sono strumenti miopi, che non affrontano il problema alla radice. Non si può continuare a trattare la casa come leva economica per far girare il mercato».
Secondo lei, la vera urgenza è rimettere al centro l’affitto sociale: «Dobbiamo smettere di considerare la casa soltanto come bene d’investimento. Va riportata alla sua funzione primaria: garantire il diritto all’abitare, con canoni accessibili». Ma non si tratta solo di costruire più alloggi. «Il nodo è la rendita», spiega, «bisogna ripensare il sistema urbanistico e fiscale in modo che l’interesse pubblico non venga costantemente schiacciato da quello privato. Per decenni il pubblico ha avuto un ruolo di controllo della rendita, oggi invece è diventato sussidiario, ridotto ad agevolare gli interessi immobiliari».
Ricostruire un ruolo forte dello Stato diventa allora imprescindibile: «Non basta tamponare con incentivi episodici. Serve un’azione pubblica che torni a governare la questione abitativa, che non si limiti a stimolare l’edilizia come unico volano economico, ma che restituisca alla casa il suo valore d’uso, non solo di scambio».
Guardare all’Europa, cambiare l’immaginario
All’estero non mancano esempi che mostrano come si possa tenere insieme diritto all’abitare e sviluppo urbano. In Germania e in Spagna, i movimenti di cittadini hanno avuto un ruolo decisivo nel rafforzare le politiche pubbliche: a Berlino, i comitati hanno imposto il dibattito sull’esproprio delle grandi società immobiliari; a Barcellona, le lotte per la casa hanno spinto il Comune a introdurre vincoli sull’edilizia turistica e a destinare una quota delle nuove costruzioni all’affitto sociale.
E c’è anche il modello danese, spesso dimenticato nel dibattito italiano: «In Danimarca», ricorda Gainsforth, «esiste un settore non profit molto forte, con cooperative che gestiscono il patrimonio abitativo e lo mantengono accessibile. È un esempio virtuoso perché dimostra che è possibile costruire un’alternativa solida al mercato privato, garantendo affitti equi e spazi abitativi di qualità senza trasformare la casa in merce».
Perché in Italia, allora, è così difficile immaginare strade simili? Qui pesa una cultura immobiliare radicata. «La casa è vista come eredità, simbolo di stabilità, investimento sicuro. È il bene rifugio per eccellenza. Questo immaginario rende difficile pensare ad alternative», riflette Gainsforth.
Eppure, l’esperienza storica insegna che senza mobilitazione non ci sono svolte possibili. «Le conquiste degli anni Sessanta e Settanta nacquero da proteste e lotte. Senza mobilitazione non si cambia. Serve una nuova coscienza collettiva: l’abitare riguarda tutti, non solo chi è in difficoltà».