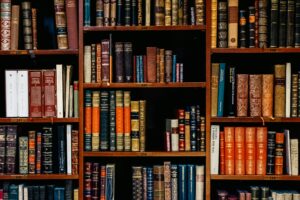Finanziarizzazione, turistificazione, gentrificazione: cosa sta succedendo alle nostre città?
“Città in affitto”, l’inchiesta del collettivo Gessi White, ci mostra come la speculazione immobiliare, la gentrificazione e il turismo di massa stiano trasformando le nostre città, ridisegnando i quartieri, lasciando sempre meno spazio ai residenti e rendendo l’abitare un privilegio per pochi.
Tempo di lettura: 6 minuti

di Annie Francisca
Autrice specializzata sui temi di sostenibilità, esteri e diseguaglianze sociali.

Succede all’improvviso. Stai camminando per le strade della tua città e ti accorgi che le vetrine non sono più quelle di una volta, i volti dei vicini sono spariti, e dove prima c’erano citofoni con nomi di famiglie ora brillano le key box dei bed&breakfast. È allora che capisci che qualcosa è cambiato e che il tuo quartiere non ti appartiene più.
Da questa sensazione nasce “Città in affitto. Un requiem per il diritto all’abitare”, pubblicato da Laterza e firmato dal collettivo Gessi White, nato all’interno della redazione investigativa IrpiMedia. Un libro d’inchiesta che scava dietro le quinte della trasformazione urbana italiana, raccontando come i nostri centri storici si stiano svuotando di vita per riempirsi di “posti letto”, gestiti da fondi immobiliari e piattaforme globali, spesso invisibili e lontane. Un racconto corale che attraversa Milano, Bologna, Roma per mostrare come il diritto all’abitare, un tempo riconosciuto come fondamento del vivere comune, stia scivolando via, trasformandosi in un privilegio per pochi.
A coordinare il lavoro di scrittura sono Lorenzo Bagnoli, condirettore di IrpiMedia; Alice Facchini, giornalista indipendente che si occupa di disuguaglianze, diritti e ambiente; e Maurizio Franco, giornalista che indaga le nuove forme di esclusione e sfruttamento nelle città contemporanee.
La finanziarizzazione della casa
Al centro dell’inchiesta c’è un cambiamento profondo nel modo in cui viene percepito l’abitare: «La casa non è più vista come un bene d’uso, secondo cui io la compro per viverci e utilizzarla, ma come un bene di scambio sui mercati di borsa, e quindi come asset finanziario», spiega la giornalista Alice Facchini. «Questa è la logica della finanziarizzazione, dietro la quale c’è, ad esempio, l’acquisto di interi palazzi a Milano, con l’idea poi dopo qualche anno di rivenderli».
Il meccanismo è ormai noto nei mercati anglosassoni, soprattutto negli Stati Uniti e a Londra e il risultato è un progressivo drenaggio di alloggi dal mercato abitativo tradizionale. «Se io tolgo un pezzo di case dal mercato perché le uso per fare compravendite finanziarie – prosegue Facchini – è evidente che l’offerta diminuisce mentre la domanda resta stabile, se non cresce, e i prezzi salgono».
A rendere tutto ancora più complesso è l’opacità dei soggetti coinvolti. «La finanziarizzazione è difficile da raccontare perché ha attori spesso non individuabili. I fondi real estate che comprano e vendono immobili sono a loro volta composti da altri fondi, che raccolgono investitori diversi sotto grandi ombrelli societari. È un sistema in cui diventa complicato capire chi sia davvero responsabile delle scelte che trasformano interi quartieri».
Milano, Roma e Bologna
Le tre città analizzate dal collettivo – Milano, Bologna e Roma – hanno un tratto comune: sono territori «ad alta tensione abitativa», spiega Facchini. «Parliamo di luoghi in cui la crisi della casa ha raggiunto un nuovo livello di intensità, al punto che il mercato non risponde più ai bisogni delle persone ma alle aspettative degli investitori». E quindi, gli affitti aumentano rapidamente nel giro di pochi anni e intere fasce di popolazione vengono espulse, perché non riescono più a permettersi di viverci.
Milano è il terreno dove la finanziarizzazione del mercato immobiliare appare con maggiore nitidezza: fondi immobiliari che comprano interi lotti, operazioni di riqualificazione che si traducono in rincari dei canoni e una competizione costante tra speculatori e residenti.
Bologna, invece, è il laboratorio, ormai esplosivo, delle città universitarie: «Qui la competizione è tra popolazioni temporanee, studenti e turisti, che si contendono gli stessi alloggi», continua Facchini. «Molti proprietari preferiscono la locazione breve a uso turistico perché è più redditizia e questa dinamica sta progressivamente espellendo gli studenti. La difficoltà di accesso all’affitto sta diventando un ostacolo al diritto allo studio».
Roma, infine, rappresenta un’altra variante della stessa crisi: quella delle metropoli dove la gentrificazione non si ferma al centro storico, ma avanza verso le periferie, trasformando interi quartieri. «Qui la pressione non è concentrata in una sola zona: si muove in onde che cambiano la geografia sociale della città», spiega Facchini. «La distanza tra chi può permettersi di abitare vicino ai servizi e chi è costretto a spostarsi sempre più in là aumenta, e questo crea una frattura profonda: non solo economica, ma anche culturale e sociale».
Una falla sistemica
Gessi White ricostruisce come le amministrazioni locali abbiano progressivamente abbandonato la pianificazione pubblica dell’abitare: i fondi per l’edilizia popolare sono stati tagliati, gli alloggi sociali ridotti, mentre le politiche cittadine si sono spostate su incentivi fiscali e partnership con il settore privato. «Fin dagli anni ’90 la casa pubblica ha perso forza», spiega Facchini. «Si è iniziato a vendere parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica perché non c’erano più soldi per ristrutturare. E così, per far entrare liquidità nelle casse degli enti pubblici si è deciso di vendere. Ma questo ha semplicemente ridotto il numero di alloggi disponibili per le persone che ne avevano bisogno».
La spirale, negli anni successivi, non ha fatto che peggiorare. «Adesso, per esempio, è stato azzerato il fondo per la morosità incolpevole, cioè per chi non riesce più a pagare l’affitto non per scelta, ma perché si ritrova senza reddito», sottolinea Facchini. Invece, come si legge su IlSole24Ore, per le famiglie che fanno fatica a sostenere il costo dell’affitto non è stata messa in campo alcuna misura: il Fondo sociale per l’affitto rimarrà vuoto anche il prossimo anno, lasciando senza sostegno chi oggi spende una quota eccessiva del proprio reddito per la casa.
Tra chi paga un prezzo molto alto ci sono anche le cosiddette “fasce grigie”, le persone che guadagnano troppo per accedere alla casa popolare, ma non abbastanza per sostenere i prezzi del libero mercato. «Uno degli strumenti che avrebbe dovuto aiutarla era il contratto a canone concordato: tariffe calmierate per l’inquilino e forti agevolazioni fiscali per il proprietario. Ma oggi quelle tariffe, fissate Comune per Comune, sono troppo basse per essere competitive. Risultato: nelle grandi città ai proprietari conviene pagare le tasse piene ma affittare sul libero mercato», spiega la giornalista.
Rendere le nostre città più abitabili
«Rendere le città abitabili per le persone non è solo una questione sociale o di diritti», spiega Facchini. «È anche una questione di sopravvivenza degli stessi organismi urbani. Se le città diventano vetrine fatte per turisti o per investitori, dopo un po’ perdono linfa vitale. E la linfa vitale sono le persone che abitano davvero il territorio, che lavorano e che tengono accesi i servizi. Se queste persone non riescono a trovare un alloggio, la città perisce».
Per questo, sostiene, «la casa deve tornare a essere un punto nevralgico delle politiche pubbliche. Non solo perché l’abitare deve essere un diritto garantito a tutti, ma anche perché, dal punto di vista economico, il sistema non regge. Bisogna tornare a stabilire regole chiare: controllare gli affitti brevi, fissare tetti alle tariffe, tassare gli immobili vuoti. Sono misure che renderebbero il capitalismo immobiliare meno feroce e ridurrebbero l’impatto sulle persone», conclude la giornalista.