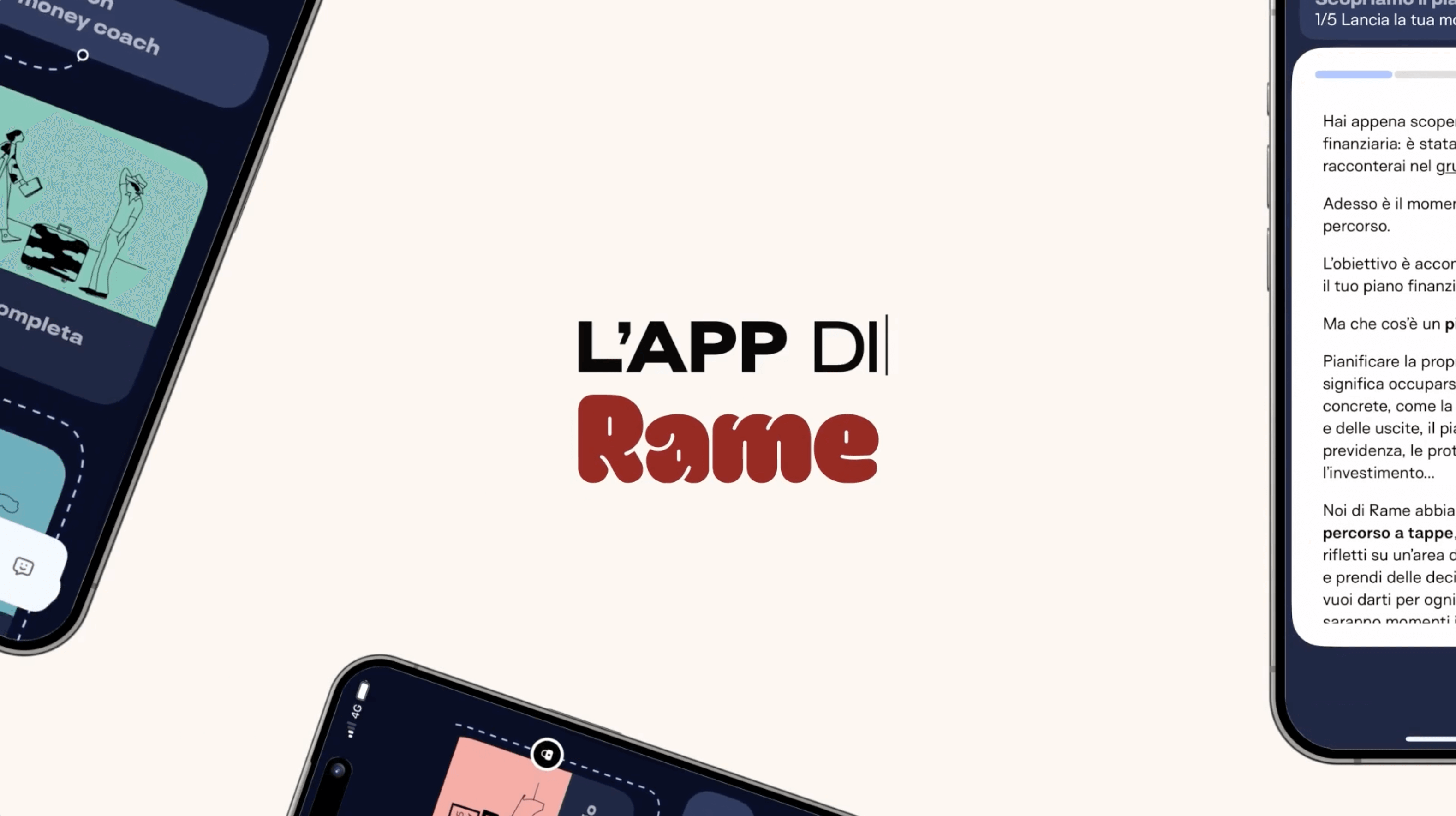Bullshit jobs: perché chi fa lavori inutili viene pagato meglio?
Molti di noi hanno la percezione di fare “lavori del cavolo”, altrimenti detti bullshit jobs, termine coniato dall’antropologo David Graeber per indicare quelle professioni percepite da chi le fa come inutili, se non dannose. Provocano insoddisfazione e frustrazione. E mentre netturbini, trasportatori e portantini – i cosiddetti “shit jobs”, umili ma indispensabili -, hanno stipendi minimi, queste professioni, paradossalmente, sono ben remunerate.
Tempo di lettura: 7 minuti

di Giorgia Nardelli
Giornalista esperta di diritti dei consumatori e finanza personale.

In tempi di Great resignation si torna a parlare di “lavori del cavolo” – bullshit jobs -, termine coniato dall’antropologo David Graeber per indicare quelle professioni percepite da chi le fa come inutili, se non dannose. Provocano insoddisfazione e frustrazione ma, paradossalmente sono ben remunerate. «Un tempo lavoravo in banca, settore consulenza. Esistevamo solo per soddisfare richieste random dal dipartimento della banca, che esisteva solo per fare queste richieste random. I manager di entrambi i dipartimenti avevano tutti gli incentivi a tirar su progetti fuffa, altrimenti avrebbero perso il lavoro. Ricostruivamo la stessa roba 10 volte con tecnologie diverse, si abbandonava dopo 2 anni e si ricominciava da capo».
A sfogliare Reddit, tema “lavoro” si trovano una valanga di sfoghi come quello di S. Lavoratori ben pagati, se non prestigiosi riconosciuti socialmente, ma consapevoli di non fare nulla di buono per la società, se non il contrario. «Penso che buona parte del mio lavoro fosse non solo inutile ma dannoso, direi parassitario: le risorse economiche erano sprecate su progetti che non avevano alcun ritorno se non soddisfare l’ego di un dirigente, e non vengono impiegate per fare cose davvero utili per la crescita aziendale», scrive V.
Bullshit job vs shit jobs
Sono tantissimi a pensarla così, specie nelle grandi organizzazioni, e non da oggi, tanto che nel 2018 l’antropologo David Graeber, sul tema ha dedicato un saggio che ha fatto il giro del mondo, il cui titolo riprendeva la definizione che lo studioso ha coniato ad hoc per quei mestieri: «bullshit jobs, in altre parole “lavori del cavolo”, in contrasto a quelli che invece sono i lavori socialmente utili, ma umili, tradizionalmente conosciuti come “shit jobs”, pagati poco, spesso logoranti e usuranti, come può esserlo fare le pulizie, trasportare merci, lavorare come portantino negli ospedali». Graeber affermava provocatoriamente che se i primi hanno una grossa utilità sociale e sono indispensabili, dei bullshit jobs si potrebbe tranquillamente fare a meno, senza che questo provocherebbe conseguenze reali per la società. Soprattutto, di questo sono persuasi i “bullshit worker” stessi.
«Chi svolge un lavoro di questo tipo è convinto che se anche lo cancellassero da un momento all’altro, nessuno ne sentirebbe la mancanza, e questo racconta bene la frustrazione e l’insoddisfazione di chi vive questa situazione», spiega Edoardo Lozza, professore ordinario di Psicologia dei Consumi e del Marketing e Psicologia Economica all’Università Cattolica di Milano, nonché autore di alcuni lavori sul tema. «Quando Graeber ha elaborato questa tesi ha condotto centinaia di interviste, dimostrando come fosse diffusa questa percezione, ma diverse survey successive condotte in Uk e Olanda hanno rivelato quanto sia rilevante la quota di persone che si sente in questa condizione. Pare che sia tra il 20 e il 30% della popolazione lavorativa».
Shit jobs vs bullshit jobs
Non esiste la fotografia esatta del bullshit job. Al di là della posizione, molto dipende dalle mansioni e dalla percezione che chi le svolge ne ha, a volte dalla struttura aziendale. Scrive B., sempre su Reddit: «Bullshitting jobs per grandi corporation da più di 20 anni. Sempre multinazionali. Banche di investimento a Londra, ora Barcellona. (…) Parole e Power Point possono coprire per il tempo che si vuole qualsiasi cosa. Ora lavoro da casa 3 o 4 giorni su 5. Copro principalmente i processi legati a governance, risk e compliance. Tutto chiaro? No? Esatto!».
«Parliamo in linea generale di professioni intellettuali, legati spesso alla finanza e il marketing, perlopiù mai indispensabili», dice Lozza, che in un editoriale dal provocatorio titolo: “Ci sono bullshit jobs fra le professioni de marketing”, pubblicato su una rivista specializzata, sottolineava qualche anno fa che anzi, tra le professioni dle marketing fosse diffusa soprattutto la sensazione di essere dannosi, socialmente deleteri, oltre che superflui.
«La pandemia, almeno nelle sue prime fasi di lockdown sembra quasi avere dimostrato questa percezione. Quando all’inizio tutti ci siamo dovuti fermare per paura del contagio, gli unici a essere rimasti operativi sono stati autisti, trasportatori, operatori sanitari, cassieri, mentre molti di quelli che svolgevano bullshit jobs, come gli addetti al marketing, per le prime settimane sono rimasti a girarsi i pollici senza che nessuno sentisse l’urgenza di riattivarli, nonostante il fatto che si trattasse a volte di lavori prestigiosi, con buoni stipendi».
All’origine della disparità
Resta il paradosso delle retribuzioni, per cui ciò che è indispensabile viene posizionato nella nostra società agli ultimi gradini, pagato poco o quasi nulla nel peggiore dei casi, mentre professioni percepite come superflue sono tra le meglio retribuite. Le ragioni ovviamente sono numerose, dovute a diverse componenti. «Banalmente, viviamo in un sistema capitalistico, in cui si viene pagati sostanzialmente per il valore economico che si produce, più che per l’utilità del servizio che si offre, e questo da solo spiegherebbe perché un addetto al marketing di una multinazionale ha remunerazioni ben superiori di un cassiere. A questo, però, si associano altri fattori che hanno poco a che fare con le logiche di mercato e le ragioni economiche».
«Quando Graeber, per esempio, parla di bullshit jobs nelle grandi organizzazioni, fa riferimento a condizioni simili a un neofeudalesimo, grandi manager che tendono ad attorniarsi di schiere di collaboratori come fossero vassalli, per aumentare la percezione della propria potenza. Alla lunga quei lavoratori avvertono di essere lì soprattutto per dare lustro al manager, e sentono tutta la loro inutilità». In compenso, aggiunge lo studioso, esiste una sorta di invidia morale da parte di chi svolge queste professioni, nei confronti dei lavorati umili, che anche se mal pagati, possono se non altro fregarsi del merito di avere un ruolo indispensabile.
Il trauma dei lavoratori inutili
Dalle interviste condotte dallo studioso era emerso che molti tra coloro che ritengono di avere un ruolo sterile o dannoso vivono una sorta di trauma, dovuto al fatto di sentire il loro mancato impatto nel mondo, e dalla convinzione di trascorrere 8 ore al giorno davanti a un computer senza che questo generi alcun valore. Nemmeno le buone retribuzioni, prosegue Lozza, riescono a placare questo senso di inutilità, sempre più marcato: «In un certo senso Graeber è stato profetico, perché molto della Graet Resignation a cui assistiamo da qualche anno, la fuga di lavoratori anche ben pagati che cercano un senso alla loro vita professionale e privata, ha a che fare con l’esigenza di sentirsi realizzati. Oggi a distanza di anni dall’inizio della fuga, non ci sono segnali di remissione del fenomeno».
A peggiorare la sensazione di inappagamento e confusione morale – prosegue Lozza – è il fatto che i protagonisti sono lavoratori dipendenti. «La percezione che ciò che fai è non buono e spesso danneggia altri, è accompagnata dalla consapevolezza che non sei tu a guidare l’azione, a decidere il come, né tu ne trarrai alcun vantaggio, se non lo stipendio. Sei semplicemente un soggetto alle dipendenze di un altro che si arricchisce in qualche modo dall’inutile mansione che svolgi, e nessuna busta paga o premio in denaro può lenire il malessere generato da questo fatto».
La bullshit work experience
Nonostante l’esodo da certe posizioni, il fenomeno dei bullshit jobs non diminuisce, tutt’altro. C’è un altro fenomeno parallelo che gli si affianca. E cioè l’aumentare della percezione, anche in categorie di lavoratori “utili”, di vivere bullshit work experience, cioè di sentirsi appesantiti da incombenze inutili, che rendono noioso e sfiancante il proprio lavoro. «L’esempio canonico è quello dei medici e del personale universitario, sempre più caricati di mansioni burocratiche, che tolgono energie e risorse agli altri ambiti», dice Lozza.
Di recente l’accademico ha pubblicato uno studio in cui indaga questo aspetto tra un campione di lavoratori dell’Università Cattolica durante un processo di accreditamento dell’Ateneo. «Nel corso di questo lavoro ci siamo resi conto quanto la compilazione di scartoffie, burocrazia, incida in maniera negativa sul benessere, indipendentemente dalla posizione dalla retribuzione. Uscirne però è possibile, condividendo il malessere che emerge dagli aspetti “bullshit” del proprio lavoro e provando collettivamente a trovare soluzioni che medino tra la pura ribellione e la necessità di ottemperare a certi obblighi e certe funzioni, per quanto odiose».