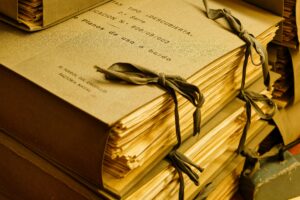Mettersi in proprio e non farcela, i consigli per “fare pivot”
Mai sentito parlare di pivot? E’ “l’operazione” che startupper e neoimprenditori si trovano a fare quando realizzano che il loro modello di business va ripensato. Traslato nella vita di tutti i giorni, è un punto di svolta di fronte al quale si può trovare chiunque si lanci in una nuova avventura professionale, e riceve i segnali che qualcosa non va. Cambiare rotta aiuta ad affrontare la sensazione di fallimento, e analizzare i fatti con lucidità aiuta a svoltare o saper tornare indietro, se è il caso, senza per questo lasciarsi sopraffare. Ecco i nostri consigli.
Tempo di lettura: 9 minuti

di Giorgia Nardelli
Giornalista esperta di diritti dei consumatori e finanza personale.

- Primo passo, liberiamoci dai miti
- Tutti i danni del “Sunk cost bias”
- Terzo step, mettersi in proprio non vuol dire “Il mio progetto non sono io”
- Il potere della self-compassion
- I segnali da riconoscere, quando un “pivot” è necessario
- Il fallimento e l'analisi come tappa del percorso
- L’importanza di saper cambiare rotta
- Un'esperienza che vale un tesoro
- L’alternativa al lavoro in proprio: tornare in azienda
Non tutte le ciambelle escono col buco, e succede anche quando ci lanciamo in un progetto professionale in cui abbiamo investito anima, corpo e risparmi. Sappiamo bene che rinunciare a uno stipendio sicuro per mettersi in proprio in un’attività autonoma o in un’impresa vera e propria comporta sacrifici e rischi finanziari, ma non sempre siamo pronti ad accettare che l’idea non ha attecchito, che i guadagni non bastano, che non si riesce a camminare sulle proprie gambe.
Analizzare i fatti con lucidità, però, serve anche a cambiare rotta o saper tornare indietro, senza lasciarsi sopraffare dal senso di fallimento. Un po’ come succede alle startup che “fanno pivot”, analizzano cioè i dati e impostano un cambiamento strategico, trasformando la crisi in opportunità. Abbiamo chiesto dei consigli a una psicologa e a una startupper. Eccoli.
Primo passo, liberiamoci dai miti
«Cominciamo facendo un passettino indietro» premette Paola Iannello, professoressa associata di psicologia all’Università Cattolica di Milano, dove insegna tra le altre cose Psicologia Economica. «Quando parliamo di attività imprenditoriali o individuali, siamo condizionati da un questione di sottofondo, e cioè da una narrazione collettiva che vede l’imprenditore insistere fino all’estremo, anche nei momenti più neri, fino a che non ce la fa. È una narrazione non sana, perché tralascia un aspetto essenziale: la maggior parte dei progetti attraversa fisiologicamente una o più fasi di “crisi”, e cioè fasi in cui le cose non vanno come ci si aspettava».
«È del tutto normale, perché i progetti, per funzionare, hanno bisogno di aggiustamenti continui, a volte di essere rivoluzionati. Andare avanti quando i segnali ci sono tutti è deleterio, ma non ce lo hanno insegnato. Quello che non ci hanno detto, è che invece la crisi è un’occasione per aggiustare il tiro».
Tutti i danni del “Sunk cost bias”
C’è un altro ostacolo psicologico che ha a che fare con il mettersi in proprio, e spesso ci spinge a “non mollare” o a non cambiare direzione anche quando sarebbe razionale farlo, ed è il cosiddetto bias dei costi irrecuperabili, o “sunk cost bias”. «È un meccanismo psicologico che, anche quando le cose stanno andando malissimo, ti frena, ti impedisce quasi di tornare indietro, semplicemente perché hai già investito tanto, soprattutto a livello economico. La volontà di recuperare ciò che si è “già speso” ha la meglio. È ciò che ci porta a pensare: “Dopo tutti i soldi investiti, l’impegno emotivo ed economico, non posso buttare via tutto senza provarci ancora”».
«In realtà, se ci fermassimo a ragionare, ci renderemmo conto che perseverare in quella direzione non fa altro che farci perdere ancora più tempo e denaro. È lo stesso principio – documentato – che in geopolitica ha spinto governi a proseguire in guerre già fallimentari, nonostante le perdite economiche e umane», dice Iannello. «Bisognerebbe invece concentrarsi sull’idea che ogni nuovo investimento e sforzo non fa che aggravare la perdita finale, il costo già sostenuto appartiene ormai al passato, è andato, e il solo modo per limitare i danni è tirare una riga, riorganizzarsi e ripartire».
Terzo step, mettersi in proprio non vuol dire “Il mio progetto non sono io”
Per guardare le cose con lucidità, infine, va superato un terzo condizionamento mentale, che fa sì che noi ci identifichiamo totalmente nel nostro progetto. «Gli imprenditori sono innamorati della propria idea, la considerano una propria creatura, tendono a non riconoscerne i limiti, a pensare che siano gli altri a “non essere in grado” di comprenderla», dice Laura Basili co founder di Women at business, piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende.
Il distacco è invece parte integrante del processo, come consiglia la psicologa Paola Iannello. «Il legame è fondamentale, sostiene lo slancio, ma è nello stesso tempo pericoloso, perché ogni errore diventa un attacco alla propria autostima. Non è questa la prospettiva giusta. Anche se in un’attività abbiamo messo tutti noi stessi, noi non siamo il nostro progetto, se questo non va, o fallisce non significa che noi siamo dei falliti».
«Quello che bisognerebbe ripeterci, in questi momenti, è che certo, il progetto è nostro, ma è altro da noi, e accettare che possa avere vita autonoma. Richiede tanta fatica, ma è possibile uscirne, razionalizzando».
Il potere della self-compassion
La parola chiave, aggiunge la psicologa, è consapevolezza: «Riconoscere ciò che si prova senza esserne travolti e senza negarlo, e senza accusarsi. Per smussare il senso di fallimento si può adottare quella che in psicologia è nota come self-compassion, potremmo spiegarla come quell’atteggiamento che ci porta a trattare noi stessi come tratteremmo il nostro amico in difficoltà, con gentilezza, riconoscendo per prima cosa i meriti, le competenze, le qualità, analizzando i fatti con una visione realistica. Non significa nascondere che qualcosa non ha funzionato, ma riconoscere il fallimento provando a decentrarsi, senza autocommiserazione, consapevoli di limiti e potenzialità, normalizzando quello che dopotutto è un processo naturale».
I segnali da riconoscere, quando un “pivot” è necessario
Avere un atteggiamento più distaccato aiuta anche a riconoscere i segnali che, nelle fasi negative, non mancano affatto. Conto in banca, business plan mostrano chiaramente trend e difficoltà in modo tempestivo, e sarebbero sufficienti per dire stop. Dice Basili: «Se la crescita è piatta, i ricavi in calo, c’è un tasso di abbandono nell’utilizzo dei servizi o dei prodotti, il prodotto e il servizio che avevi immaginato non vengono utilizzati come speravi, tutti questi dati ti dicono non è l’offerta giusta, che c’è qualcosa da modificare o stravolgere».
Nel contempo, anche il corpo ci parla e ci manda dei campanelli di allarme che non dovremmo ignorare: quando la frustrazione per la fatica che si fa è superiore alla soddisfazione, quando si inizia a lavorare per non perdere, anziché che per guadagnare, per colmare anziché per costruire, arrivano ansia, irritabilità, scarsa motivazione, mancanza di gioia.
Il fallimento e l’analisi come tappa del percorso
L’atteggiamento giusto, allora, è quello che ci vede lucidi e consapevoli che mettersi in proprio è solo l’inizio, il “fallimento” può essere una parte del percorso, anzi, un punto di partenza per un pivot, un cambio di strategia. Come si traduce in azioni? Mettendo nero su bianco cosa ha funzionato e cosa no, perché non è detto che ogni cosa sia da buttare, semplicemente ci sono mille variabile che condizionano il successo o l’insuccesso di un’impresa. Lo spiega Laura Basili:
«Mettere in fila uno ad uno i dati oggettivi che hanno portato alla situazione attuale è fondamentale, perché è studiando che si arriva a soluzioni alternative. Dobbiamo sforzarci insomma di capire cosa è accaduto, partendo dai numeri, perché i numeri parlano. E poi farci delle domande. La prima è chiedersi se il servizio che abbiamo proposto quando ci siamo messi in proprio ha destato l’interesse di qualcuno, quale problema risolve, se lo risolve, a chi e a quanti. Forse l’offerta economica era troppo alta, oppure troppo bassa? C’è modo di ritirarla per allargare il pubblico? Oppure c’è un altro bisogno da soddisfare, visto che il servizio che pensavamo di offrire vede già troppi competitor e dobbiamo intercettare un nuovo tipo di clientela?»
«Se sulla piazza ci sono già troppi web designer, vale la pena che ci sforziamo di offrire qualcosa di diverso per intercettare un altro pubblico, ponendoci nuovi obiettivi. Non si tratta necessariamente di inventare la ruota, a volte sono sufficienti poche modifiche».
L’importanza di saper cambiare rotta
A questo punto, continua Basili, possiamo identificare una nuova direzione, facendoci appunto guidare dai dati. Nel gergo delle startup, questa fase di misurazione, analisi e cambiamento si chiama pivot. «È successo anche a noi di Women at business di “fare pivot”. Quando è nata la nostra idea volevamo rivolgerci a donne che per un motivo o per un altro non avevano avuto una carriera lineare e desideravano ricollocarsi nel mondo del lavoro. Avevamo analizzato i dati sulla maternità e ci sembrava di avere una buona fetta di pubblico».
«In realtà, quando siamo state pronte, nel 2020, il Covid aveva stravolto lo scenario, ci siamo rese conto che avremmo dovuto spostarci su un’idea di business differente, sì al femminile, ma che riguardasse tutte le donne, dai 18 anni in avanti. C’erano nuovi bisogni, per esempio le giovanissime non sapevano dove collocarsi, perché la pandemia aveva inceppato tutti i meccanismi di domanda e offerta. Abbiamo mantenuto il nostro core business, ma siamo cambiate».
Un’esperienza che vale un tesoro
Può succedere, però – e accade – che l’analisi porti a conclusioni diverse, e allora anche saper fare un passo indietro, con il giusto atteggiamento, è salvifico. «La fase dell’analisi dovrebbe sempre essere accompagnata da una riflessione su chi siamo e cosa vogliamo», consiglia la startupper. «Se anche nella crisi restiamo convinte che l’obiettivo è lavorare in proprio, essere indipendenti e gestire le nostre giornate, fare qualcosa di nostro, allora il fallimento è appunto l’occasione per fare tesoro dell’esperienza e modificare la strategia».
«Ma c’è anche da fare un’analisi sulle competenze che ci occorrono per lavorare in proprio: intraprendenza, empowerment, coraggio, sono caratteristiche che non tutti possediamo, e non tutti siamo in grado di reggere lo stress di arrivare a fine mese solo con le proprie forze, rischiando. Questa parte non va tralasciata, perché potrebbe portarci a concludere che il lavoro autonomo o l’imprenditoria non è la nostra vocazione, o semplicemente che avremmo bisogno di un partner che si occupi di aspetti che noi preferiamo non gestire».
L’alternativa al lavoro in proprio: tornare in azienda
Detto questo, è anche d’aiuto la consapevolezza che tornare al lavoro dipendente dopo un’esperienza in proprio non è necessariamente un fatto negativo. «Non un tornare indietro, ma un andare avanti in altro modo, dopo aver capito che quella non era la tua strada», sintetizza Basili. E allora ci si rimette in campo e si valorizza la propria esperienza anche sul curriculum, si torna a fare i colloqui di lavoro con uno spirito differente: sapendo cosa si vuole e cosa ci può soddisfare, e che l’esperienza conclusa ha fatto crescere o sviluppato competenze che possiamo portare in un’impresa.
«Coraggio, intraprendenza, leadership, capacità di portare idee nuove sono doti molto apprezzate nelle aziende, ed è bene sapere che possiamo “mettere a reddito” la spinta che ci ha portato a fare quel passo, anche se di mezzo c’è stato un fallimento. Anche spiegarlo a chi abbiamo di fronte, non è così difficile. Ogni storia imprenditoriale si regge su motivazioni ed esperienze diverse, ci sono spesso ragioni oggettive per cui si è arenata, non sempre e non solo c’entra la capacità di chi la guidava».