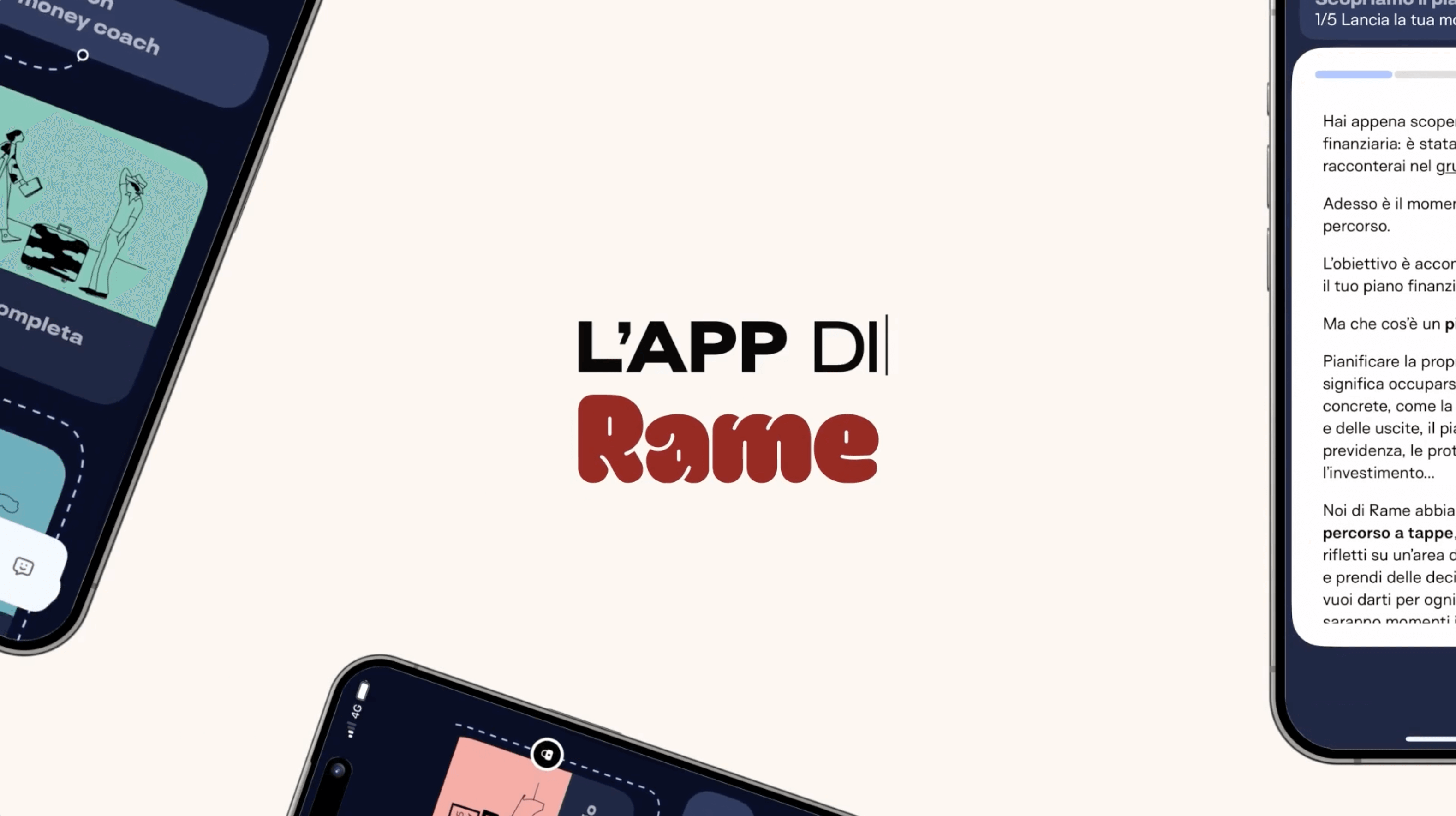Quel giorno ho lasciato andare i miei gioielli (e la mia autostima)
Nella sua infanzia in provincia di Salerno, Mariachiara Montera è testimone dell’ascesa sociale dei suoi genitori, figli laureati di gente umile, ma anche degli errori di valutazione di suo padre sulla gestione dei soldi, che causano alla famiglia periodi di incertezza. Mariachiara vive l’obiettivo dell’autonomia economica come il riscatto dalle situazioni che hanno turbato la sua giovinezza. E così, quando quell’autonomia scricchiola, è lei stessa come persona a mettersi in discussione.
Tempo di lettura: 12 minuti

“Ho venduto la mia bellissima macchina fotografica e pure alcuni gioielli. È stato difficile, proprio come nei film. Quando lasci andare un gioiello, benché verso di esso non provi nessun trasporto, perché non l’hai mai indossato, in quel momento lasci andare una parte di te, che è la parte che avrebbe dovuto sostenersi, la parte che avrebbe dovuto essere adulta. È un momento di sfiducia molto forte e anche di confronto impietoso con gli altri. Perché tu stai facendo un gesto che dimostra al mondo che non sai mantenerti, che non sei autonoma, che non sei adulta ma fingi di esserlo”.
Perché Mariachiara sia arrivata a vendere i suoi gioielli e come quell’episodio sia diventato un momento cruciale del suo percorso di ricostruzione, è la storia che oggi vi voglio raccontare. Ma come sempre, iniziamo dal principio.
Mariachiara Montera ha 42 anni e vive a Torino. È una content creator, ossia una creatrice di contenuti, ma anche un’esperta di marketing. Quando racconta la sua infanzia a Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, Mariachiara rievoca due immagini in particolare.
Una riguarda i suoi nonni.
«Mio nonno paterno faceva il contadino e girava per il paese a bordo di un asino, o almeno io me lo ricordo così. E mia nonna, anche di lei mi ricordo i suoi animali perché aveva le galline in soffitta».
L’altra immagine riguarda i suoi genitori.
«Ricordo questo dettaglio incredibile: sulla targhetta del citofono c’era e c’è ancora scritto il loro titolo di studio. Dottor Montera e professoressa con il cognome di mia madre».
Nati tra il ’45 e il ’48, la madre e il padre di Mariachiara erano stati protagonisti di un’emancipazione culturale, e quindi economica, rispetto alle famiglie di partenza. Avevano studiato all’università ed erano diventati lui medico e lei professoressa delle medie. Mariachiara e sua sorella vivono dunque un’infanzia molto tranquilla: una cameretta tutta per loro, le vacanze nella casa in affitto in Calabria e i viaggi a Venezia per vedere la Biennale.
Le cose, però, iniziano a cambiare intorno ai 10 anni.
“Ho cominciato a sentire un rapporto diverso con i soldi, quando sono cominciati a mancare. Io adesso non so ricostruirti la storia economica di questi scossoni, so che sono avvenuti, ma non so quantificarteli. Quello che mi veniva detto era che il lavoro di mio padre non andava così bene, c’era un momento di crisi, dovevamo tirare la cinghia, questo jeans non te lo possiamo comprare e così via”.
Ciò che spesso succedeva, a quei tempi, era che l’aumento di ricchezza non andava di pari passo con l’aumento delle competenze per gestire quella ricchezza. E il ritrovarsi in difficoltà dopo aver studiato e raggiunto posizioni sociali importanti provocava disagio, imbarazzo, ansia.
«Il tema dei soldi era uno dei principali argomenti di discussione in casa. C’era una fortissima critica nei confronti di mio padre da parte di mia madre, sfogata con noi figlie. Credo che fosse l’unico sfogo che lei potesse avere perché avveniva nella dimensione privata della famiglia».
I genitori di Mariachiara finiranno per divorziare ormai quasi settantenni. E lei, più volte proverà a capire se e come quei soldi venissero sperperati, ma invano.
«Non è stato facile avere questa conversazione con loro. Credo che entrambi provassero vergogna rispetto a una gestione che forse legittimamente non è stata sempre liscia. Soprattutto perché su di loro pesava lo spettro del passaggio generazionale, di competenze e di classe sociale».
La vergogna provata dai genitori per non essere stati all’altezza diventa, in qualche modo, l’eredità emotiva di Mariachiara. La sua sfida è essere meglio di così.
“L’autonomia è il mio riscatto. Se riesco a essere autonoma significa che sono abbastanza brava da non finire più in certe situazioni che da piccola non mi hanno fatto stare benissimo e dimostrano che sono una persona che sa prendersi cura di se stessa”.
Ed è per raggiungere quel traguardo di autonomia che Mariachiara, dopo la laurea nel 2005, cerca il posto fisso. L’incertezza della libera professione, che ha vissuto attraverso suo padre, non può permettersela.
«Credo che una parte dell’identità con cui sono cresciuta vedesse il posto fisso come realizzazione di un “io” di successo, stabile, borghese. L’essere “sistemata” credo che faccia parte di tantissima parte della mia generazione».
Per sette anni, fino al 2013, Mariachiara lavora in azienda. È pienamente autonoma dalla famiglia di origine, e da quello che nel frattempo è divenuto suo marito. Poi però, nel 2013, decide di mettersi in proprio. E qui la narrazione non è esattamente quella a cui ci stiamo abituando negli ultimi tempi.
“Il mio mettermi in proprio è stata una risposta a un mercato economico dove quell’essere sistemata non esisteva più. Nel 2013 tante aziende erano già in crisi. Oggi c’è questo mito di licenziarsi per inseguire i propri sogni… Io mi sono licenziata la prima volta dalla Fnac perché era un’azienda in crisi, che da lì a due anni avrebbe chiuso. Mi sono licenziata la seconda volta da un’azienda della Regione Lombardia perché la vedevo scricchiolare e infatti dopo due anni ha chiuso”.
Il passaggio a libera professionista non è semplice, ma Mariachiara ce la fa e inizia a ingranare. A metterla in difficoltà, nel 2015, è un avvenimento di tutt’altra natura: il divorzio da suo marito. Che comporta una serie di spese straordinarie dovute alla ricerca di una nuova casa e alla necessità di arredarla.
«È stato il primo momento adulto in cui ho avuto serie difficoltà economiche. Ed è stato anche il momento in cui ho venduto degli oggetti perché non sapevo come fare. Mentre succedeva, non l’ho raccontato a nessuno, mi sembrava un’onta».
La narrazione con cui Mariachiara è cresciuta prevede che l’autonomia sia la misura del successo. E nei momenti in cui quell’autonomia scricchiola è lei stessa, come persona, a sentirsi messa in discussione.
“Forse è qualcosa che affronterò in psicoterapia prima o poi, però sento un forte senso di fragilità in questa ricerca di autonomia. Da una parte penso che sia qualcosa di identitario e legato alla mia storia. Dall’altra parte penso che sia qualcosa legato alla narrazione con cui siamo cresciuti e cioè: ‘devi far perno su te stessa, sulle tue capacità per realizzare la vita che vorresti’. Come se le nostre condizioni di partenza non contassero”.
«In realtà, è una grande sciocchezza. Purtroppo mi capita di provare invidia verso persone che, alla mia età, hanno una casa e una stabilità diversa. Io mi paragono soltanto nel momento presente, quando in realtà dovremmo vedere da quali famiglie siamo stati cresciuti, in quale condizioni economiche, che scuole abbiamo fatto, che possibilità abbiamo avuto».
«Conosco pochissime persone che saprebbero far fronte a spese impreviste, contando sul proprio stipendio e sui propri risparmi. Perché la condizione di fragilità è comune. Non si può dire, però, perché dobbiamo tutti dire che siamo bravi, che siamo autonomi, ma ogni tanto abbiamo alti e bassi e in questi alti e bassi, se non te la sai cavare da sola, ti aiuta la tua famiglia. Ma non molti lo ammettono. Questo è il racconto collettivo che dovrebbe essere cambiato per modificare il nostro orizzonte di paragone. Con chi e con quali condizioni di partenza ci stiamo paragonando?».
Mentre se ne sta in fila davanti al compro oro o, subito dopo, mentre chiede il suo primo prestito in banca, Mariachiara questa consapevolezza ancora non la possiede.
«Non ne dicevo molto bene di me in quel momento, ecco perché non raccontavo a nessuno ciò che stavo vivendo. Anni dopo, quando ne ho parlato, mi sono accorta che in realtà avevo fatto qualcosa di molto sensato. È stato il modo in cui ho sopperito a una mancanza di fondi, un modo che mi ha fatto tenere dritta la barra. Era un momento difficile, l’ho superato. E l’ho superato da sola. Chapeau».
La seconda volta in cui Mariachiara si trova a dover sostenere una spesa imprevista è nel 2018. L’anno prima aveva accettato nuovamente un lavoro dipendente e si era ritrovata a sommare due redditi. Quando arriva la batosta delle tasse, capisce che deve chiedere nuovamente un prestito in banca.
“Quando parlo di prestito, noto una reazione un po’ strana delle persone. Come dire: ‘Non hai degli affetti?’ ‘Sei sola?’ ‘Povera bambina!’. A parte che non è detto che tutte le famiglie abbiano i mezzi, ma non è detto che tutte le persone abbiano l’indole o la relazione per chiedere soldi alla propria famiglia”.
Potendo contare esclusivamente sulle sue forze, Mariachiara non solo ha dovuto chiedere due prestiti in banca. Ma ha dovuto anche rinunciare a una serie di cose, come la casa per esempio.
«Da quando mi sono messa in proprio, è un desiderio che ho sempre avuto. Sono andata anche in banca per capire se la mia frustrazione di non comprare casa fosse concreta o se invece potevo permettermelo. Ho scoperto che con il mio reddito annuale posso permettermi al massimo un bilocale in zona super periferica, ma comunque devo avere un capitale di partenza che non ho, quindi il progetto di comprare casa non c’è. A un certo punto, ho chiesto una mano a mio padre chiedendogli di vendere la casa in cui vive come nuda proprietà. Mio padre all’inizio mi ha detto di sì, con mia grandissima sorpresa. Poi ha cambiato idea. Sulla carta perché non ho figli, e quindi secondo lui non valeva la pena per me comprare una casa perché tanto a chi l’avrei lasciata? Ma la verità è che credo che abbia avuto molta paura di perdere l’unica cosa che possiede».
Oggi, sono quasi dieci anni che Mariachiara naviga nei mari burrascosi della libera professione e nell’incertezza della partita Iva.
“Ho provato a creare delle condizioni lavorative per cui la stabilità economica fosse la parte principale della soddisfazione lavorativa, sia da un punto di vista fattuale sia emotivo. Io lavoro per soldi. Non lavoro per i sogni, anche perché i soldi ti danno accesso alla vita. E se tu quei soldi non te li sai guadagnare da sola, che vita fai? Quante volte esci? Quanti libri ti puoi comprare, quanti regali puoi fare, quanti regali puoi farti? I soldi sono la possibilità che hai di vivere secondo il benessere che desideri. Sono la forma che tu dai al benessere”.
Grazie a questa visione pragmatica del lavoro, Mariachiara, anno dopo anno, ha imparato a darsi il giusto valore.
«All’inizio non avevo un’idea chiara di come andassero costruiti i prezzi, perché non avevo nessuna idea dei costi. Anni dopo ho iniziato a tenere conto di tutte le spese che faccio. Uso un’applicazione che si chiama Monefy, dove vado a inserire ogni voce, dai viaggi ai trasporti, alle bollette. Tutto. Così ho un’idea chiara di quali sono le mie uscite mensili e di quanto dovrei guadagnare per coprire quelle spese e avere un margine che mi permetta da una parte di vivere tranquilla e dall’altra di accantonare. Spoiler: ancora non accantono».
Oltre all’esatto calcolo delle spese che si sostengono, c’è anche un’altra considerazione da fare quando si tratta di darsi un prezzo.
«Una cosa che ho imparato col tempo è stato chiedermi quali sono i vantaggi che do alla persona o all’azienda con il mio lavoro? E quindi ho imparato a stabilire il mio valore rispetto a questo doppio asse».
Ma cosa succede quando un cliente ti dice che costi troppo?
«Questa cosa non mi spaventa, nel senso che mi deprime un po’ ma d’altra parte il lavoro è sempre una relazione e la relazione deve essere fatta di fiducia e comprensione del valore. Quindi, se la relazione parte con una valutazione diversa, amen: non siamo fatti per stare insieme».
La libera professione rimane sempre una montagna russa emotiva. Le chiedo come fa a gestire l’incertezza delle entrate e di conseguenza a pianificare la sua esistenza.
«Nei momenti in cui ho delle difficoltà, reagisco sempre nello stesso modo. Tanatosi: quindi chiusura di ogni tipo di emozione, non sta succedendo niente, non accolgo nessun dolore, se non per 5 minuti, inventandomi una ragione esterna, tipo che non ho i peperoni. Poi, seconda reazione: “Okay, agiamo. Troviamo un modo per guadagnare di più”. Quindi la mia reazione è sempre fare, fare, fare, non fermarmi mai».
Nel suo lavoro, per lungo tempo Mariachiara ha creduto di non potersi permettere la parte creativa, ovvero quella parte ad alta soddisfazione ma meno remunerativa. Negli ultimi due anni, però, qualcosa è cambiato.
«Sto mettendo a frutto tante cose che fanno parte di una sfera che non pensavo che fosse legittima prima di mettermi in proprio, come i podcast, i libri. Purtroppo, però, questo è stato l’anno in cui i lavori creativi sono stati molto belli ma ho fatturato di meno. Forse mi sono adagiata sulla possibilità che il lavoro creativo mi avrebbe portato ad altri lavori creativi pagati di più».
Ancora una volta, tocca fare un bagno di realtà e cercare la propria soddisfazione nel compromesso tra attività remunerative e attività appassionanti.
“Guardo sempre con maggiore amarezza la passione che metto in cose che mi piacciono, perché penso che quella passione sia la moneta con cui mi pago tutto quell’impegno. Io vorrei mantenere la passione. Ma mi piacerebbe anche far sì che il mio lavoro sia più stabile e questo significa venire a patti col fatto che il lavoro creativo non potrà mai sostenermi al 100%”.