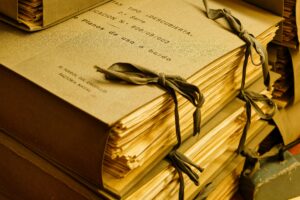Il regime forfettario è iniquo e costoso. Parola di economisti
Il regime forfettario piace alle Partita Iva perché riduce la tassazione e semplifica la contabilità. Ma secondo il Fondo monetario internazionale è una misura iniqua e costosa, che per di più non incentiva la crescita e favorisce il sommerso. A pensarla così, in realtà, è più di un economista. Sorpresi? Ecco come potrebbe essere migliorata.
Tempo di lettura: 4 minuti

di Giorgia Nardelli
Giornalista esperta di diritti dei consumatori e finanza personale.

Il popolo delle Partite Iva ama il regime forfettario. Del quasi mezzo milione di soggetti e imprese ha aperto un’attività nel 2024, circa la metà, il 46,9% ha scelto l’imposta sostitutiva fissa al 15%, e se si considerano solo autonomi e professionisti la percentuale si impenna. Da quando nel 2015 è stato istituito con la legge di bilancio, il regime forfettario è stato accolto come una manna, soprattutto da chi ha redditi medio bassi e poche o zero spese da detrarre o dedurre. L’imposta secca al 15%, un’aliquota decisamente di favore rispetto alla tassazione ordinaria, fa da contrappeso alle incertezze, alla precarietà alla mancanza o quasi di tutele che oggi caratterizzano il lavoro autonomo.
FMI: «Il regime forfettario è iniquo e costoso»
Lo scorso maggio, però, il regime forfettario è finito nel mirino del Fondo Monetario internazionale, che nel suo ultimo rapporto sull’Italia lo ha definito una misura iniqua, dagli effetti distorsivi, oltre che costosa, consigliandone l’abolizione. Il sistema è sotto accusa perché favorisce i lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti, che non possono eludere in nessun modo l’Irpef a scaglioni, ma crea delle disuguaglianze anche tra gli stessi autonomi. Senza contare che l’esistenza di due regimi fiscali paralleli induce a “comportamenti elusivi” e scoraggia la crescita.
«In realtà, il regime forfettario è nato con le migliori intenzioni», spiega Francesco Scinetti, junior Economist dell’Osservatorio sui Conti Pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano. «Più un sistema fiscale è prevedibile per Stato, imprese e lavoratori, più la programmazione e la pianificazione diventano semplici. Inoltre, la flat tax al 15% per le partite Iva fino a 65.000 euro di fatturato, come era stata concepita in un primo momento, rispondeva all’esigenza semplificare per i redditi medio bassi un sistema fiscale che tra detrazioni, deduzioni e scaglioni risultava assai complesso, e riduceva anche la spesa relativa alla contabilità per le piccole partite Iva. A lungo andare, però, specie con le ultime modifiche, è stata sacrificata l’equità».
Un regalo ai redditi medio-alti
Il nodo? Intanto, dal 2023 la possibilità di accedere alla tassa piatta del 15%, prima concessa solo a chi non fatturava oltre i 65.000 euro lordi l’anno, è stata estesa fino a 85.000 euro. Secondo le stime presentate dal governo in occasione della manovra, la misura ha un costo di un miliardo ogni tre anni, ma non si conoscono i dati aggiornati. Ad ogni modo, non solo l’innalzamento del tetto ha favorito le fasce di reddito che già possono definirsi medio alte, ma ha acuito le disparità tra chi può accedere al regime di favore e chi no, anche considerando che per chi comincia, e possiede determinati requisiti, nei primi anni di attività l’aliquota è fissa al 5%.
La simulazione e le differenze con il sistema a scaglioni
Per capire di cosa parliamo è sufficiente una simulazione: «Un autonomo che in un anno fattura 85.000 euro all’anno e ipotizzando un coefficiente di redditività al 78%, paga con il regime forfettario (tralasciando per semplicità i contributi previdenziali) circa 9.945 euro di tasse. Se l’anno successivo fattura un euro lordo in più, verserà al Fisco circa 29.190 euro di Irpef. Vero è che l’importo va depurato di deduzioni e detrazioni, che il regime forfettario non considera, ma per arrivare a “pareggiare” dovrebbe avere spese altissime. Chiaro che chi rischia di sforare è incentivato a fatturare meno, o a non dichiarare».
La nostra Costituzione – spiega Scinetti – ci dice che la tassazione deve essere progressiva, con l’aumentare del reddito dovrebbe cioè salire anche l’aliquota da versare al Fisco, e da qui nasce il regime fiscale attuale a tre scaglioni. Il meccanismo attuale prevede che fino a 28.000 euro si versi al Fisco il 23%, l’aliquota scatta al 35% solo per la quota di reddito che supera questa soglia, così come sale al 43% solo per la parte sopra i 50.000 euro. «Tradotto: se sono nel regime ordinario e fatturo 55.000 euro all’anno, pagherò il 23% sui primi 28.000, il 35% sulla parte tra i 28.001 euro e i 50.000, e il 43% sui restanti 5.000. Verserò sì più Irpef con il salire dei ricavi, ma ciò che entra in più non comporterà per me una perdita, come invece succede se supero la soglia degli 85.000 euro nel forfettario».
Le soluzioni? Un’imposta più progressiva
A questo si aggiunge il tema della sproporzione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. «È impensabile che un autonomo con un fatturato da 85.000 euro all’anno abbia una tassazione più favorevole di un dipendente che ha un reddito annuo lordo di 25.000 euro», riflette Scinetti. Eppure, qualche soluzione, pur senza abolire del tutto il regime forfettario ci sarebbe: «Un’idea su cui spesso si ragiona è quella di rendere l’imposta più progressiva, così da evitare il “balzo” che si ha quando si passa dal forfettario all’ordinario, oppure riducendo il massimale della flat tax: un fatturato da 85.000 euro annui non giustifica un trattamento di favore».