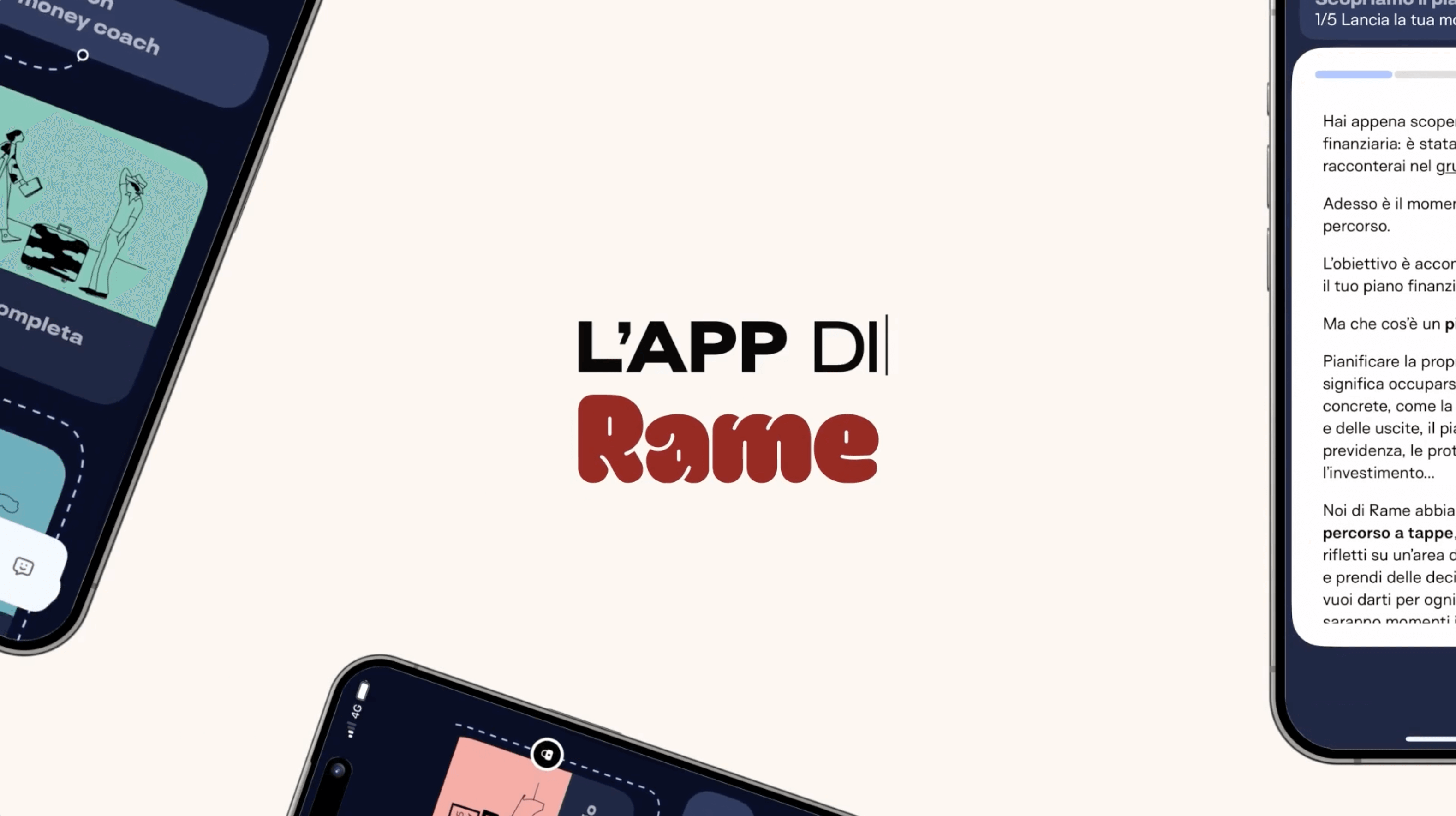I soldi ho imparato a lasciarli andare
Sofia Borri nasce nell’Argentina del 1976, sotto una delle dittature più feroci del Novecento. All’età di due anni viene rapita assieme a sua mamma, militante di un partito di opposizione. Dopo qualche giorno, viene riconsegnata ai nonni, mentre sua madre sparisce per sempre, come succede ad altri 30mila desaparecidos. Mesi dopo riuscirà a ricongiungersi con suo padre, in Brasile, e da lì a partire alla volta dell’Europa assieme a un gruppo di sopravvissuti. Dopo 4 anni in Svezia, Sofia arriva in Italia. Sono anni di grandi ristrettezze ma lei non ricorda neppure un momento in cui i soldi siano stati una vera preoccupazione.
Tempo di lettura: 10 minuti

“Ricordo sempre mia nonna Renata, che a un certo punto nel ’79 aveva un figlio esiliato in Svezia, che era mio papà, e l’altro suo figlio Carlos, che era esiliato in Canada. Anche lui era scappato. E a un certo punto ha iniziato a vendersi tutto per viaggiare, per vedere i suoi figli”.
«Lei mi raccontava che aveva un bracciale d’oro bellissimo che le aveva regalato mio nonno in occasione di un anniversario di matrimonio, che lei aveva poi venduto. Credo che lì metta le radici quella che è un po’ una caratteristica della mia cultura, e cioè l’idea che i soldi sono uno strumento. Che è bello avere delle cose, infatti lei mi parlava di quel bracciale come qualcosa a cui era molto affezionata, però se a un certo punto ti serve per fare altro, devi lasciar andare».
La nostra relazione con i soldi, ci dicono gli studi, è condizionata da innumerevoli fattori: la personalità, il genere, l’impronta familiare, la cultura del Paese di appartenenza, le vicende economiche collettive vissute nell’infanzia. Ecco, nella storia che raccontiamo oggi, tutti questi condizionamenti si intrecciano tra loro in un nesso inestricabile.
Sofia Borri nasce nell’Argentina del 1976, sotto una delle dittature più feroci del Novecento. «Mia madre era una militante di un partito e nel febbraio ’78 è stata sequestrata per non far più ritorno a casa, così come altre 30.000 persone e tanti e tante compagni del del loro partito».
Quella notte di febbraio, in cui sua madre diviene una desaparecida, Sofia viene rapita assieme a lei e dopo qualche giorno riconsegnata ai nonni. Mesi dopo riuscirà a ricongiungersi con suo padre, anch’egli militante, in Brasile, e da lì partire alla volta dell’Europa assieme a un gruppo di sopravvissuti.
Gli anni svedesi
«Le Nazioni Unite in quel momento ti dicevano: “Puoi chiedere asilo politico dappertutto perché è un diritto internazionale. Però conviene la Svezia, che in questo momento è molto accogliente”. Quindi noi siamo arrivati lì. Io lo dico sempre: dai 40 gradi di Rio de Janeiro ai -30 di Stoccolma… senza niente».
Sofia e suo padre vivono per 4 anni in Svezia in un tempo sospeso, con lo sguardo sempre volto alle vicende politiche argentine, a chi era rimasto lì, a capire quando tornare, e come resistere.
«Noi siamo arrivati lì e non solo ti veniva data una casa: se volevi studiare ti venivano pagati gli studi, se volevo lavorare ti veniva dato un lavoro. Il primo periodo lo abbiamo passato in una specie di campo profughi nel sud di Stoccolma, in mezzo a un bosco. Io ho un ricordo di quel posto come di una specie di villaggio degli elfi. E poi, successivamente, ci è stato dato un appartamento per nucleo familiare per il quale pagavamo un affitto calmierato, come se fosse una sorta di housing sociale».
L’arrivo in Italia
Dopo 4 anni, l’intero gruppo di militanti si trasferisce in Italia.
«L’Italia non era stata accogliente come la Svezia. Siamo arrivati qui come immigrati qualsiasi, non come rifugiati. Non per tutti è stato facile ambientarsi e mettendo sulla bilancia le condizioni che avevamo in Svezia, qualcuno ha deciso di tornare al freddo e di ricominciare da lì».
Nel 1983 la dittatura in Argentina finisce e molti militanti decidono di tornare nel proprio Paese. Sofia e suo padre scelgono di restare in Italia.
«Ci ha trattenuto qui il fatto che mio padre si è innamorato di una donna, Nicoletta, che poi è stata la mia mamma adottiva, con cui ha deciso di costruire una famiglia. Poi sono nate le mie sorelle».
Fino al 1990 vivono a Rocca Brivio, una sorta di comune, dove ognuno ha il proprio nucleo abitativo ma all’interno della quale c’è una dimensione collettiva di gestione dello spazio. «Un posto bellissimo fuori Milano, una vecchia rocca del Settecento, che richiedeva anche un lavoro comunitario. Era un posto fricchettone».
Sofia si ritrova a vivere in una condizione di notevoli ristrettezze.
“A me non piace usare la parola povertà, perché i poveri purtroppo sono un’altra cosa. I poveri sono quelli che non hanno un tetto, quelli che non hanno opportunità, quelli che non possono andarsene dai posti orribili e violenti dove vivono. E noi non non eravamo poveri, non lo siamo mai stati, però di sicuro eravamo delle persone con una disponibilità economica molto ristretta e che devono stare molto attente ai soldi che hanno”.
«Tutto questo negli anni ’80, che in Italia era un momento di boom e di possibilità economiche per tutti».
Eppure, il rapporto con i soldi della sua famiglia è qualcosa di profondamente peculiare, forse a causa di tutto ciò che hanno vissuto.
«Io devo dirti la verità che non ho mai sentito a casa mia la preoccupazione per i soldi. E io so oggi, col senno di poi, che noi veramente veramente vivevamo col fido. Io ho delle amiche che parlano dell’andare in rosso come se fosse un delitto contro l’umanità, e invece no, si può fare, sono soldi tuoi. Quello che a me stupiva sempre della mia famiglia era che noi spendevamo i soldi per cose diverse dagli altri. Magari avevi un solo paio di scarpe, però avevi tanti libri; non facevamo le vacanze classiche nei posti di mare in Liguria o la settimana bianca, però andavamo all’estero. Quindi ho sempre avuto una misura di quello che puoi fare coi soldi un po’ diversa dai modelli che avevo intorno».
La scoperta della potenza del dono
Sofia inizia a lavorare quando ha 16 anni, fa la baby sitter, la cameriera, la ghostwriter e per un periodo si occupa persino di contare le macchine agli incroci. Eppure, decide di non investire i suoi soldi in esperienze o oggetti materiali.
«Quasi tutti i miei soldi li spendevo nella psicanalisi. C’erano dei momenti in cui mi andava in crash il cervello, perché erano gli anni dell’università, in cui lavorare così tanto avrebbe corrisposto a poter fare delle esperienze. Io però volevo investire in questa cosa perché sapevo che sarebbe stato l’investimento giusto. Col senno di poi, ho avuto ragione».
A un certo punto, dopo 4 anni di psicanalisi mentre studia Antropologia, Sofia decide che è arrivato il momento di iniziare a risparmiare per un nuovo obiettivo: andare in Erasmus. E proprio in quell’occasione, scopre la potenza del dono.
«In realtà noi abbiamo sempre avuto a che fare con persone che avevano più disponibilità economica di noi e anche un altro livello culturale. E quell’anno lì, degli amici dei miei genitori che avevano saputo che volevo fare l’Erasmus e che stavo lavorando tanto, mi hanno finanziato una borsa di studio. Mi ricordo che ero stra felice, non avevo nessuna sensazione di disagio. Ho pensato: “Hanno voluto investire in una in gamba, che se lo merita”».
Sofia e i suoi genitori accettano il dono sapendo di non poterlo restituire e anche questo appartiene alla loro cultura più profonda.
«È come se le diverse disponibilità economiche non fossero una questione di merito o demerito. E se c’è la possibilità di far circolare delle risorse vanno fatte circolare. Penso che se tutti fossimo così ci sarebbe più possibilità di fare più cose, perché riusciremmo ad alzare tutto il nostro potere d’acquisto».
“Mi piacerebbe un po’ più di permeabilità nei confini dei nostri possessi, delle case, degli spazi, degli oggetti, del denaro. Non perché tutto è di tutti ma perché esiste uno spazio che decidiamo insieme, dove le cose sono sia mie che tue. A volte ho l’impressione che anche nel dono oggi ci sia quasi una galera mentale”.
L’ingresso nel mondo del lavoro
Una volta finita l’università, Sofia inizia a cercare lavoro nel mondo del sociale. Una scelta sicuramente influenzata dal suo passato e dalla volontà di battersi per delle giuste cause.
«È stata la fine dell’università che mi ha fatto capire che dovevo provare a non pensare alla mia sopravvivenza come a un accrocchio di lavoretti. E lì, ho avuto la meravigliosa e malaugurata idea di decidere di lavorare nel sociale. Quello che ho acquisito con l’età è che in questo ambiente, come nell’ambiente culturale, tante volte c’è un po’ questa pretesa che a pagarti sia l’amore per l’oggetto di lavoro. Per un po’ mi sono adattata a questa cosa e ho pensato che fosse giusta».
Dopo anni di contratti precari, Sofia però capisce che vuole altro.
«La molla è stata, credo, quella di uscire da una dimensione organizzativa che sentivo un po’ soffocante, perché io mi sentivo con una spinta imprenditiva molto forte che all’interno di quella realtà era spenta».
Ed è così che Sofia dà una svolta imprenditoriale alla sua vita, ovviamente nel sociale. Diventa socia di Piano C, una startup che si occupa di formazione e inserimento lavorativo delle donne.
«Mi sono misurata con la dimensione del dare un lavoro equo e giustamente pagato, perché fare impresa non è procacciarsi lavoro ma creare opportunità che poi diano lavoro. E questo è stato uno switch mentale importante. Ma che lavoro creo? Che lavoro do alle persone?».
La svolta imprenditiva
Dopo qualche anno, però, Sofia capisce che la solitudine dell’imprenditrice non è una dimensione che le appartiene. Così decide di cambiare la forma sociale della sua attività. Oggi Piano C è un’associazione iscritta al registro del terzo settore.
«È un’associazione puramente sociale con una leadership condivisa, ma non solo: noi sappiamo il tipo di lavoro che creiamo e cerchiamo di dargli un valore che sia condiviso, e quindi sappiamo anche che dobbiamo dare alle persone la libertà di stare dentro o fuori Piano C, facendo ciò che in quel momento corrisponde alle proprie necessità economiche e di realizzazione professionale».
Che posto occupano i soldi, oggi, nella gerarchia della preoccupazioni di Sofia?
«A volte mi dà fastidio dover pensare ai soldi perché non ne ho abbastanza, ma rinuncio facilmente alle cose che non mi posso permettere. Milano è una città faticosa in questo. Penso alla casa di proprietà, per esempio, che io non ho e che non mi posso permettere e che non mi comprerò a Milano. Perché? Perché il prezzo da pagare è troppo alto, perché mi dovrei indebitare in un modo che per me non ha senso e perché inciderebbe sulla qualità della mia vita oggi. Però è difficile centrarsi sempre su questo pensiero. Così come è difficile distaccarsi dall’idea che i soldi che guadagni e lo status professionale non vadano a braccetto con il chi sei. In questo la mia cultura argentina è un apprendimento continuo: quello è un Paese che ha vissuto degli shock economici inimmaginabili, per cui dall’oggi al domani il denaro non vale più niente».
“Ogni tanto mi guardo intorno e vedo gente che si preoccupa per delle cose di cui non ha senso preoccuparsi. Questo mio background culturale mi dà una leggerezza enorme a cui attingo nei momenti di preoccupazione”.
Le chiedo se avere delle figlie abbia sfidato un po’ questa leggerezza…
«Che bella domanda Annalisa. Questo è il terreno dove a volte la pressione sociale rispetto a quello che sto garantendo alle mie figlie la sento. Però poi ci penso e mi dico che mi sbatto come un’acciuga, loro vivono in una città con mille opportunità… Questa non è una mia responsabilità. Sarà una responsabilità loro, quella di usare al meglio le risorse che troveranno, di trovarne di nuove che la famiglia non ha datoloro. Ho fiducia nel fatto che sapranno trovare la loro strada. Non darò loro denaro. Ma ci sarò, in un altro modo».