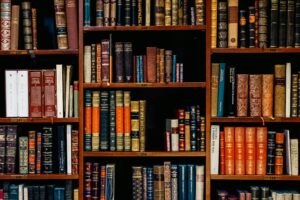Extraprofitti delle banche: cosa prevede la nuova tassa (e chi ne pagherà davvero il conto)
Da una parte ci sono le famiglie che ogni mese vedono crescere le rate del mutuo. Dall’altra, le banche che registrano utili mai visti prima. È l’immagine di un Paese diviso dal costo del denaro: chi lo chiede lo paga, chi lo presta ne raccoglie i frutti. Ora il governo prova a riequilibrare la bilancia con un contributo straordinario sui profitti del settore finanziario, una misura che punta a restituire qualcosa ai conti pubblici, ma che apre una domanda cruciale: questa volta, chi pagherà davvero il conto?
Tempo di lettura: 5 minuti
di La redazione

Da una parte ci sono le famiglie che vedono crescere le rate dei mutui e fanno i conti con un credito sempre più caro. Dall’altra, le banche che negli stessi mesi segnano utili da record. È la fotografia di un Paese in cui il costo del denaro non pesa per tutti allo stesso modo: chi lo chiede ne paga il prezzo, chi lo presta incassa dividendi mai visti. Ora il governo prova per la seconda volta (un primo esperimento era già stato attuato nel 2023) a riequilibrare la bilancia con una tassa sui “super profitti” del settore. Ma mentre l’esecutivo rilancia l’idea di un contributo straordinario, le banche avvertono che potrebbero esserci ripercussioni sui clienti. Insomma, la vera domanda è: chi pagherà davvero il conto?
I profitti record del settore
Negli ultimi anni il sistema bancario italiano ha visto crescere i suoi margini a livelli mai registrati prima. Secondo la FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), nel 2024 le banche italiane hanno realizzato un utile netto di 46,5 miliardi di euro, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente, e nel triennio 2022-2024 hanno cumulato oltre 112 miliardi di euro di profitti. Dietro questi numeri c’è soprattutto l’aumento dei tassi deciso dalla Banca centrale europea, che ha ampliato il cosiddetto margine d’interesse, ovvero la differenza tra quanto le banche guadagnano dai prestiti e quanto pagano ai risparmiatori sui depositi.
Cosa prevede il governo
Nella bozza della manovra economica, il contributo richiesto a banche e assicurazioni ammonterebbe a circa 4-5 miliardi di euro. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che «se su 44 miliardi di profitti nel 2025 ce ne mettono a disposizione cinque, possiamo essere soddisfatti». Tuttavia, la misura non è una vera “tassa sugli extraprofitti”, bensì un contributo straordinario che il settore dovrebbe versare a sostegno dei conti pubblici. Secondo Il Corriere della Sera, il governo punta a raccogliere fino a 11 miliardi in tre anni, ma all’interno della maggioranza restano divisioni e non tutti condividono la misura.
Perché non la chiamano più “tassa sugli extra profitti”?
In realtà, la nuova manovra non introduce una vera e propria “tassa sugli extraprofitti” come nel 2023, ma ne conserva lo spirito. Quel primo tentativo – previsto dal Decreto Asset e mai davvero applicato fino in fondo – imponeva un prelievo del 40 % sui guadagni extra legati all’aumento dei tassi. Oggi il governo cambia strategia, ma non obiettivo: fare in modo che una parte degli utili straordinari del settore bancario torni alle casse pubbliche. Nel testo bollinato della Legge di Bilancio 2026, questo avviene attraverso due strumenti principali. Il primo è l’articolo 20, che riattiva il contributo straordinario introdotto nel 2023 e stabilisce che le banche che vogliono distribuire ai soci le riserve accantonate due anni fa devono pagare un’imposta sostitutiva del 27,5% o del 33 %, a seconda del momento in cui lo fanno. In altre parole, una tassa più alta per chi aveva “congelato” gli utili per evitare la precedente.
Il secondo è l’articolo 21, che aumenta di due punti percentuali l’aliquota dell’IRAP per banche e assicurazioni dal 2026 al 2028. Insomma, anche se formalmente non si parla più di “extraprofitti”, l’effetto è lo stesso: un prelievo aggiuntivo mirato al settore bancario, che agisce sia sui guadagni passati sia su quelli futuri.
Le conseguenze possibili per famiglie e imprese
La prima reazione delle banche è stata chiara: se lo Stato impone un contributo straordinario, una parte del costo potrebbe essere trasferita ai clienti. L’effetto più immediato riguarderebbe il credito. Secondo BeBankers, nel 2024 le grandi banche italiane, pur registrando utili record, hanno ridotto i prestiti netti di circa 22 miliardi di euro. Una pressione fiscale aggiuntiva rischierebbe di accentuare la tendenza, rendendo i finanziamenti più selettivi e costosi.
Il secondo effetto potrebbe manifestarsi sui servizi bancari: conti correnti, carte, commissioni. Se il margine operativo diminuisce, gli istituti possono compensare aumentando costi accessori o riducendo condizioni favorevoli. Infine, c’è un possibile impatto indiretto sull’economia reale. Come ha osservato Altreconomia, «qualsiasi colpo agli utili delle banche si traduce in una contrazione dei prestiti e in un aumento degli oneri per i clienti». In altre parole: se le banche frenano, rallenta anche l’economia.
Un esempio pratico
Immaginiamo una banca che deve versare un contributo straordinario che riduce i suoi margini di 0,5 punti percentuali. Se decidesse di recuperare quella perdita aumentando i tassi sui mutui di pari importo, per un prestito di 150.000 euro a vent’anni la rata mensile crescerebbe di circa 25-30 euro, ossia fino a 7.000 euro in più nel corso del mutuo. Non è una previsione, ma una misura di quanto velocemente la leva del credito può trasmettere gli effetti fiscali ai consumatori.
Cosa possono fare i risparmiatori
Per chi usa una banca, la vera difesa è sapere leggere le condizioni. Controllare sempre i tassi effettivi, confrontare le offerte e chiedere spiegazioni su ogni voce di costo, dalle commissioni ai tassi applicati ai mutui. Esistono piattaforme indipendenti che permettono di verificare in pochi minuti le differenze tra un istituto e l’altro, incluse le banche digitali.
È utile anche ribaltare la prospettiva: non solo chiedersi quanto si paga, ma quanto si riceve. Qual è il tasso riconosciuto sui propri depositi rispetto a quello applicato sui prestiti? Infine, diversificare può essere una scelta prudente: affidarsi a più istituti, valutare cooperative di credito o realtà trasparenti che reinvestono nel territorio. Ancora una volta, in un sistema dove i profitti si concentrano in alto, la conoscenza resta la forma più solida di equità.